![]() Costruire in pietra
Costruire in pietra
Sul finire del X secolo si assiste ad
un mutamento radicale nell’attività architettonica in Normandia.  Essendo
tantissime le distruzioni dovute alle invasioni vichinghe e così scarse le
tracce del periodo precedente,
Essendo
tantissime le distruzioni dovute alle invasioni vichinghe e così scarse le
tracce del periodo precedente,  spesso
si è trascurata la continuità operante soprattutto dal regno di Riccardo I
(942-996) e da quello di Riccardo II (996-1026). Quel complesso di competenze
ereditate dalla tradizione romana e trasmesse attraverso il periodo carolingio
si riscontra nelle chiesette parrocchiali anteriori al decennio 1030-1040. I
muri sono, a quell’epoca ancora, costruiti in piccolo apparecchio di brecce
alternantesi a una catena di mattoni, con effetto policromico da mettere a
confronto con le mura romane della città vicina, Le Mans. A testimoniare
ugualmente di una tradizione antica è il persistere nell’uso dell’opus
spicatum, ossia la disposizione delle pietre a spinapesce.
spesso
si è trascurata la continuità operante soprattutto dal regno di Riccardo I
(942-996) e da quello di Riccardo II (996-1026). Quel complesso di competenze
ereditate dalla tradizione romana e trasmesse attraverso il periodo carolingio
si riscontra nelle chiesette parrocchiali anteriori al decennio 1030-1040. I
muri sono, a quell’epoca ancora, costruiti in piccolo apparecchio di brecce
alternantesi a una catena di mattoni, con effetto policromico da mettere a
confronto con le mura romane della città vicina, Le Mans. A testimoniare
ugualmente di una tradizione antica è il persistere nell’uso dell’opus
spicatum, ossia la disposizione delle pietre a spinapesce.
Tale tradizione è presente anche nei grandi edifici
attraverso il richiamo  prestigioso
all’architettura carolingia, conservato e sviluppato nell’impero germanico,
ricordo questo molto vivace nelle vicende del regno come nelle regioni situate
all’est del ducato. All’inizio dell’XI secolo, Fécamp come Jumièges
seguono la planimetria caratteristica delle chiese con massiccio occidentale
inquadrato da robuste torri. Ma la Normandia risulta anche aperta alle influenze
delle regioni vicine : Maine, Angiò e Loira ; dall’altro lato, ci
sono nella cerchia ristretta del duca i monaci riformatori a introdurre nel
ducato modelli diversi, provenienti dall’Italia, nati in Borgogna o ispirati
anche al successo dell’ordine cluniacense.
prestigioso
all’architettura carolingia, conservato e sviluppato nell’impero germanico,
ricordo questo molto vivace nelle vicende del regno come nelle regioni situate
all’est del ducato. All’inizio dell’XI secolo, Fécamp come Jumièges
seguono la planimetria caratteristica delle chiese con massiccio occidentale
inquadrato da robuste torri. Ma la Normandia risulta anche aperta alle influenze
delle regioni vicine : Maine, Angiò e Loira ; dall’altro lato, ci
sono nella cerchia ristretta del duca i monaci riformatori a introdurre nel
ducato modelli diversi, provenienti dall’Italia, nati in Borgogna o ispirati
anche al successo dell’ordine cluniacense.
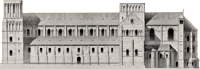 L’architettura
romanica normanna, negli anni 1020-1050, si sta delineando in maniera
progressiva sui cantieri di Fécamp, di Jumièges e di Saint-Wandrille, nonché
quelli del Mont-Saint-Michel, di Rouen o di Bernay. È
a Bernay, durante il decennio 1020-1030 circa, che compaiono quelle decisive
innovazioni : l’altimetria con tre piani,
L’architettura
romanica normanna, negli anni 1020-1050, si sta delineando in maniera
progressiva sui cantieri di Fécamp, di Jumièges e di Saint-Wandrille, nonché
quelli del Mont-Saint-Michel, di Rouen o di Bernay. È
a Bernay, durante il decennio 1020-1030 circa, che compaiono quelle decisive
innovazioni : l’altimetria con tre piani, 
 con grandi arcate a tutto sesto
poggianti su pilastri compositi, un piano intermedio di bifore, e delle finestre
a livello superiore illuminanti la navata. In seguito, la maestria costruttiva
permetterà soluzioni nuove quanto audaci, come l’apertura di grandi gallerie
superiori soprastanti le navate laterali, nonché il passaggio attraverso una
galleria di camminamento dentro lo spessore del muro stesso, davanti alle
finestre alte. Le varie tappe di tale progressione sono segnate da esempi quali
Notre-Dame di Jumièges, ultimata nel 1067, da Cerisy-la-Forêt o da
Saint-Etienne de Caen, sul finire dell’XI secolo…. Infine, i primi
voltamenti sopra crociera ogivale conservati in Normandia sono quelli del coro e
del transetto di Lessay, e della navata di Saint-Etienne di Caen, nell’arco di
tempo situato tra il 1100 e il decennio 1120-1130.
con grandi arcate a tutto sesto
poggianti su pilastri compositi, un piano intermedio di bifore, e delle finestre
a livello superiore illuminanti la navata. In seguito, la maestria costruttiva
permetterà soluzioni nuove quanto audaci, come l’apertura di grandi gallerie
superiori soprastanti le navate laterali, nonché il passaggio attraverso una
galleria di camminamento dentro lo spessore del muro stesso, davanti alle
finestre alte. Le varie tappe di tale progressione sono segnate da esempi quali
Notre-Dame di Jumièges, ultimata nel 1067, da Cerisy-la-Forêt o da
Saint-Etienne de Caen, sul finire dell’XI secolo…. Infine, i primi
voltamenti sopra crociera ogivale conservati in Normandia sono quelli del coro e
del transetto di Lessay, e della navata di Saint-Etienne di Caen, nell’arco di
tempo situato tra il 1100 e il decennio 1120-1130.
La pianta delle grandi chiese romaniche
normanne segue la planimetria benedettina ispiratasi a Cluny  composta di una navata con navate laterali, un transetto con
bracci sporgenti, un coro con absidiole e, all’incrocio del transetto, la
torre lanterna illuminante il santuario, andamento planimetrico illustrato
efficacemente dalle chiese di Caen -
composta di una navata con navate laterali, un transetto con
bracci sporgenti, un coro con absidiole e, all’incrocio del transetto, la
torre lanterna illuminante il santuario, andamento planimetrico illustrato
efficacemente dalle chiese di Caen - 
 Saint-Etienne, Saint-Nicolas. Il coro gradonato è sussistito nel
variegato panorama architettonico normanno, ma delle absidi con deambulatorio
sono state costruite a Fécamp, a Rouen e a Jumièges. Dal regno di Guglielmo il
Conquistatore e quindi dal periodo dei grandi cantieri di Caen, la facciata
cosidetta " armonica " prevale nella maggior parte degli
edifici. Nel pignone occidentale fiancheggiato da due torri si riscontra la
pianta della navata e delle sue navate laterali, mentre la sovrapposizione delle
arcature in facciata riproduce l’altimetria interna. Infine, la firma visiva
di quest’arte costruttiva rimane la pietra di Caen diffusa nell’intero campo
anglo-normanno.
Saint-Etienne, Saint-Nicolas. Il coro gradonato è sussistito nel
variegato panorama architettonico normanno, ma delle absidi con deambulatorio
sono state costruite a Fécamp, a Rouen e a Jumièges. Dal regno di Guglielmo il
Conquistatore e quindi dal periodo dei grandi cantieri di Caen, la facciata
cosidetta " armonica " prevale nella maggior parte degli
edifici. Nel pignone occidentale fiancheggiato da due torri si riscontra la
pianta della navata e delle sue navate laterali, mentre la sovrapposizione delle
arcature in facciata riproduce l’altimetria interna. Infine, la firma visiva
di quest’arte costruttiva rimane la pietra di Caen diffusa nell’intero campo
anglo-normanno.
Quei tratti peculiari dei grandi edifici si adeguano a loro volta a tante chiese medie e piccole, fossero di fondazione monastica o di parrocchie urbane o rurali. L’andamento planimetrico viene comunque semplificato : assenza di navate collaterali, navata ridotta a un piano inferiore e uno superiore, coro piatto, torre unica tra navata e coro o sul lato, torre-portale più rara. È in quei casi che, proprio nel coro, spesso voltato a crociera ogivale nel XII secolo, e nondimeno nella decorazione e nell’altimetria della torre, si riconoscono i tratti maggiormente originali dell’arte normanna della costruzione in pietra.